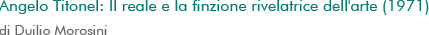Tra gli artisti cui è toccato di vivere i terrori e le miserie della guerra all'epoca della loro adolescenza molti non sono riusciti a disfarsi mai degli incubi di allora. Quegli incubi se li sono portati sulle spalle - e se li sentono pesare addosso tutt'ora, nella stagione della loro piena maturità - non solo gli uomini di natura più vulnerabile, ma quegli stessi uomini che, sorretti dalla debita lucidità dello sguardo sulle cose e dal debito rigore, intellettuale ed etico, hanno mostrato di saper cogliere - e folgorare, da osservatori, interpreti e testimoni a carico - i termini e le responsabilità dei grandi conflitti sociali del dopoguerra.
Si pensi - esempio tra gli esempi - al caso di un Guerreschi [...] che agita perpetuamente davanti ai nostri occhi l'eventualità che - sotto forme diverse, ma simili nella sostanza - la storia possa ripetersi.
Ebbene, credo che si debba passare inevitabilmente attraverso simili riflessioni per afferrare bene ciò che unisce e ciò che divide la generazione che oggi ha passato il capo dei quarant'anni da quella che dell'inferno della guerra reca un ricordo dissolto nella bruma del brutto sogno d'infanzia.
Certo, gli artisti di quest'ultima generazione condividono - quando si tratti di uomini responsabili - le apprensioni, le istanze, gli impegni di coloro che li hanno preceduti. Ma ciò che differenzia sostanzialmente i secondi dai primi è, appunto, il fatto di poter esplorare il cuore della realtà d'oggi senza quella tale, preventiva logorante "lotta contro sé stessi", senza dover fare incessantemente i conti con le ossessive memorie del passato; il fatto, insomma, di poter applicare tutte le loro migliori energie alla comprensione del presente (un presente, che d'altro canto, per l'avanzamento del processo di emancipazione dell'umanità intervenuto nel frattempo, offre alla riflessione prospettive sensibilmente diverse da quelle degli anni della guerra fredda, nei quali i quarantenni di oggi sono venuti a maturazione).
Tant'è vero che il divario è percepibile allo stesso livello delle scelte culturali. Anche il quarantenne d'oggi (e penso ancora alla personalità della tempra di un Guerreschi) ha mirato e mira, come il giovane d'oggi, al linguaggio freddo e lapidario, ma ha dovuto e deve "convincere" prima di ogni altro sé stesso dell'odierna inefficacia di un'arte di protesta basata sul grido, sul gesto (insomma sul comportamento "apocalittico").
Altrimenti vanno le cose per l'artista maturatosi in quella tale, diversa situazione oggettiva, per il quale rientra, in qualche modo, nell'ordine delle riflessioni "spontanee" l'idea di dover fare - oggi - i conti con Forme di potere capaci delle più sanguinose violenze là dove esse si avverino "produttive" (si pensi alle cosiddette guerre localizzate, scatenate all'ombra del ricatto atomico) ma governate, d'altro canto - dovunque ciò sia possibile, o, meglio, inevitabile, per non subire scacchi - da idee di dominio basate su di un'opera tanto metodica, quanto allettante nelle apparenze, di quotidiana "pacificazione", di quotidiana, indolore sterilizzazione delle coscienze.
A queste situazioni di fatto - e convinzioni - va rapportata la diffusa tendenza, fra gli artisti impegnati delle ultime leve a rendere quanto più attivi possibile gli scambi tra l'immagine dotata di valore cognitivo e critico (insomma, di potere liberatorio) e, rispettivamente, le immagini - variamente intenzionate - di valore ricognitivo (reperibili nei réportages) o di valore convenzionale-strumentale (provenienti dal repertorio ottico della persuasione di massa). Ebbene tra le varie correnti - da studiare in altra sede - che fanno capo a questa tendenza, il filone cosiddetto documentaristico non si sta sviluppando, oggi, come una delle tante alternative possibili in vista di un'autentica, non "mistificata" "comunicazione di massa", ma in modo massiccio; anzi, in una maniera in qualche modo abnorme. Tanto da mettere in vista il rischio che la severità di un'esigenza oggettiva volga alla volubilità dell'esibizione di risorse tecniche: tanto da rischiare di confondere, agli occhi dello spettatore poco avveduto la passiva adozione degli strumenti analitici della fotografia e del cinema con l'utilizzazione mediata della loro ottica, con la competizione con essa e, addirittura, con lo smascheramento di certi loro inganni.
* * *
È in un simile contesto - di generazione, di tendenza e di inquieta consapevolezza delle "chances" e delle insidie inerenti alla ricerca in questione - che si colloca la pittura (l'autore non si serve - lo rilevo incidentalmente - di tecniche di riporto) del giovane Angelo Titonel.
Per questo, presentando l'anno scorso una sua "personale" singolarmente impegnativa a Roma, lamentavo la carenza (sentita, ovviamente, in modo particolare in una simile congiuntura culturale) di studi critici che assicurino la necessaria continuità alle acute riflessioni sulla fotografia come strumento di indagine e documento di prova del processo storico di un Walter Benjamin: la carenza, cioè, di studi che portino avanti quel discorso allargandolo alla questione delle convergenze e divergenze tra i processi dell'osservazione inquisitrice suscitati dal documentarismo fotografico, e, rispettivamente, dall'oggettivismo pittorico così come si sono delineati nel quarantennio o cinquantennio che ci siamo lasciati alle spalle: a partire dalle esperienze di un determinato filone della Neue Sachlichkeit tedesca (il filone delle ricerche oscillanti fra documentarismo e "realismo magico", che fa capo ai Grossberg, Voelker, Raederscheidt) e dalle, più o meno contemporanee esperienze di uno Sheeler e di un Demuth, nell'ambito del cosiddetto precisionismo americano.
A spingermi a fare un simile ragionamento era (ed è) la convinzione che pittori orientati come lo è il giovane Titonel, da noi, e, in altri Paesi, un suo coetaneo come il tedesco Nagel, o altrove, i più anziani Monory e Colville siano, in qualche modo, dei continuatori di quella cultura e non abbiano proprio nulla a che fare - ideologicamente e formalmente - con quell'arte di réportage - impassibile e cinica - che fa capo alle diramate eterogenee esperienze della pop art americana ed europea.
* * *
Se le difficoltà, con le quali artisti così orientati hanno, da fare i conti non sono, dunque, in nessun caso, inerenti all'"arte di réportage", bisogna vedere, tuttavia, se non si tratti, per essi, di stare molto attenti alle trappole, di tutt'altra natura, nelle quali più d'uno dei pittori del "realismo magico" degli anni venti-trenta ha rischiato di cadere od è caduto.
Le "trappole" di quella sorta di "neoclassicismo a roveschio" nelle quali è caduto qualcuno degli americani, piuttosto che dei tedeschi: per un eccesso di fiducia nel progresso (ideologicamente motivato da una curiosa confluenza fra pragmatismo ed idealismo "dogmatico").
Non bisogna perdere in vista il fatto che, sia Sheeler che Demuth (provenienti da esperienze fotografiche - il primo - o da studi tecnologici - il secondo -, ma ambedue nutriti, pure, di cultura artistica europea) hanno - talora - acriticamente identificato il fascino dell'esattezza che emana dal panorama urbano e industriale con le misure (valori di sintesi e di ordinamento prospettico) di questa o quella espressione dell'arte antica o del primo rinascimento: fuori da ogni considerazione sui rispettivi contesti socio-culturali.
Non è solo la strutturazione di certi loro quadri a dirlo, ma in taluni casi, la stessa scelta dei loro titoli. Titoli per esempio "Mio Egitto" (Demuth) o "Paesaggio classico" (Sheeler), per composizioni ispirate allo "spettacolo" di complessi industriali, sorti alle frontiere della città. Ebbene, di fronte a simili episodi, il minimo che si possa dire, almeno per quegli specifici dipinti, è che ambedue gli artisti in questione vedevano nella fabbrica un oggetto di contemplazione e non un luogo di conflitti (cosa che non accadeva, invece ai tedeschi).
Certo, molta acqua è passata, da allora, sotto i ponti, ma non è detto che, per questo, simili atteggiamenti non possano riprodursi, sotto altre forme. Mi pare, anzi, che l'odierno panorama artistico non sia avaro di esempi del genere a cominciare dal più vistoso, quello della cosiddetta "arte tecnologica", per finire con quelli più larvati, ma non meno sintomatici, di certa nuova figurazione e di certa arte di montaggio di tipo "combinatorio", nei quali l'estraneità ai conflitti di base della nostra epoca è così evidente da non aver bisogno di essere motivata.
* * *
Ebbene, se è vero che un giovane artista come Titonel ha mostrato e mostra di essere consapevole di simili rischi, è anche vero che la medesima consapevolezza investe le difficoltà inerenti all'impresa che lo appassiona. Per afferrarle, bisogna tornare a quella tale questione - accennata all'inizio - delle convergenze e divergenze tra documentarismo fotografico ed oggettivismo pittorico.
Avendola già trattata nella prefazione alla precedente "personale" di Titonel a Roma, estraggo, qui, un frammento di quello scritto perché esprime tuttora il mio punto di vista sulla faccenda (e perché presenta il vantaggio di essere sintetico).
Per l'artista refrattario - per "vocazione" e formazione ideologica - all'estetica della specularità dell'immagine, non si tratta - dicevo - di operare tagli selettivi su di una realtà preesistente, come accade al fotografo che dal documento visivo si applichi ad estrarre degli "indizi". Si tratta, invece di smontare e rimontare le impalcature del reale, di sperimentare le varie possibilità di relazione tra le cose. Di ordire, insomma, un "lucido complotto della ragione", che miri alla massima ambiguità tra la citazione della cronaca e la finzione rivelatrice dell'arte: così da suggerire allo spettatore diverse possibilità di lettura: così da procurargli l'illusione della libertà di scelta (analogamente a quanto accade per le tecniche della persuasione di massa), pur incanalando le sue impressioni e i suoi giudizi dentro un determinato ordine di idee (dentro l'alveo di una visione critica del reale).
Ebbene, in una pittura come quella del giovane Titonel, a far scattare la molla di quella tale "ambiguità" erano allora (e sono, anche oggi, ma con l'acquisizione, come si vedrà, di nuovi strumenti espressivi), l'isolamento dell'oggetto in un ambiente plausibile ma irrelato (oppure in uno spazio altrettanto "pertinente" ma che, ad una attenta osservazione si rivela inabitabile), e, d'altro canto - tramite una filtratissima operazione pittorica basata sulla monocromia - l'alterazione appena percettibile di un dettaglio, o, addirittura, la sostituzione, altrettanto "inavvertibile" del dettaglio stesso. A tali risorse si aggiungeva, ma con minore frequenza, quella dell'accostamento - od innesto - di fenomeni altrettanto "verosimili" ma che, una volta associati (o, piuttosto, integrati) concorrevano alla formazione, a livello allusivo, di una nuova, autonoma immagine.
Tipica, in tal senso, in quella mostra, la grande composizione che, sovrapponendo dei caschi a pile di cerchioni di automobile ed accampando il tutto contro un orizzonte, suscitava un'ambigua oscillazione tra l'idea del fotogramma scattato all'aperto, in uno dei marches aux puces che sorgono ai margini delle nostre città e quella della figurazione ironica del "manichino in carne ed ossa" dei nostri giorni (robot, uomo d'ordine).
Ebbene, restando fermi agli obiettivi di fondo di Titonel, gli obiettivi del realismo critico attento a quelle malattie sociali che sono, oggi, la fiducia indiscriminata nel valore dell'energia operativa, la passività e serialità delle scelte di modelli di consumo e di comportamento (pratico, etico, politico), e, pur restando altrettanto ferme le sue convinzioni circa il potere conoscitivo - e di persuasione - dell'arte che finge la specularità dell'immagine (dell'arte dalle intenzionalità nascoste) è a quel tale, particolare momento della sua ricerca di ieri che Titonel ha dato, ultimamente, un preponderante sviluppo: con apporti inventivi che riescono piuttosto sorprendenti, agli occhi di chi consideri che appena un anno è trascorso tra la sua "personale" a Roma e quella che presenta ora a Firenze.
La motivazione di questa sua attuale tendenza va ricerca, penso, in un ordine di riflessioni inerenti a quella stessa nozione (e pratica) della "finta" specularità dell'immagine, sulla quale Titonel ha basato (e basa tutt'ora, ma con altre implicazioni di linguaggio) il proprio "metodo" figurativo.
Titonel mostra, infatti, con le sue opere più recenti, di aver misurato, nel frattempo con crescente attenzione il rischio di identificare la funzione rivelatoria del segno freddo e "neutro" con quella del segno riduttivo rispetto alla complessità del reale, con quella del segno dotato, volutamente, (per una malintesa nozione dell'essenzialità e della totale adesione agli aspetti ed ai problemi del presente) di uno spessore culturale ben delimitato.
Certo, una cosa è proporsi di suggerire allo spettatore l'"assioma" che la realtà è sempre tutta da scoprire; proporsi, insomma, di indurlo a guardare alle cose che gli sono consuetudinarie come si guarda all'inesplorato, all'ignoto, con l'occhio e la mente sgombri dalle abitudini che pregiudicano la conoscenza ed un'altra cosa è considerare una simile prerogativa (che caratterizza, da sempre, la specificità dei processi conoscitivi dell'arte) con la convinzione di dover sacrificare all'esigenza "sociale" dello stile lapidario strumenti o processi che, poi a ragione veduta, si avverano utili, o, addirittura indispensabili: proprio in vista di quel tale stimolo alla conoscenza da suscitare nello spettatore.
Strumenti quali (in questo specifico caso) la duttilità del movimento analogico tra oggetto ed oggetto o tra dettaglio e dettaglio; l'energico rimando, tramite l'attivazione di un simile movimento, a realtà diverse da quelle rappresentate (da suggerire allo spettatore); il rimando, infine, alle esperienze indirette - alle esperienze di cultura - che, per quanto in misura estremamente variabile, giacciono nel fondo della coscienza di ogni uomo e sono suscettibili di stimolare ed accrescere le sue facoltà di giudizio.
Ebbene, è un po' su tutti questi punti, ma in particolare sull'ultimo, che mi pare Titonel abbia soffermato, con visibile profitto, la propria attenzione, da un anno a questa parte.
Già a quella tale composizione con cerchioni e caschi - poco fa citata - non era estranea l'idea di suggerire una connessione tra l'immobilità, la vacuità o la "terribilità" del fittizio personaggio creato a partire da un semplice accumulo di oggetti e le forme, di secolare eredità culturale, del busto o dell'erma. L'idea, insomma, di stimolare nello spettatore la consapevolezza della relatività dell'"inedito" che la contemporaneità gli propone, qualora egli consideri l'oggetto proposto (con tutte le sue novità di forma e di funzione) in rapporto alle motivazioni di fondo delle lotte che l'uomo conduce da sempre per la propria emancipazione.
L'idea, insomma, di invitare lo spettatore a riflettere sul fatto che, visto sotto questa luce, non c'è "oggetto moderno" che non abbia alle sue spalle una storia, al cui contesto non può sottrarsi. Ad un simile disegno, creativo e critico, vanno rapportati molti dei quadri recenti. In modo particolare, però - a mio avviso - l'intero ciclo di "ritratti" o composizioni di corridori che sono cosmonauti (o viceversa, od altro ancora: si pensi alla nota invenzione filmica di Cocteau che, in una moderna versione della mitologia greca, identifica la necessità, il destino con l'immagine del motociclista dei nostri giorni), nei quali lo stesso intervento del colore - o, se volete, il conflitto tra la varia tessitura pittorica e la monocromia "documentaristica" - fanno capo ad un simile obiettivo.
Ecco infatti, qui, delle tute che, per l'andamento "modulare" delle loro pieghe e per la loro tessitura cromatica - tra il giallo spento, l'ocra e l'avorio - sono lembi di materiale sintetico, e, insieme, di tradizionali drappi, panneggi, "sudari" (che rimandano, cioè, al tema del "costo" delle grandi avventure umane, nei suoi molteplici trattamenti, moderni ed antichi di cui ci danno conto le vicende secolari dell'arte). Ed ecco, ancora, delle tensioni o "fratture" formali - tra volti segnati dal marchio della vulnerabilità ed oggetti (i caschi) "invulnerabili".
Dove, appunto, è alle "scocche" ed agli smalti "incorruttibili" dei secondi (gli oggetti) che fa capo, in misura preponderante, quel tale movimento analogico di cui si diceva. Un movimento che si dirama in profondità - in strati subito identificabili o vagamente "imperscrutabili" - nello spessore della storia dell'arte (e, se volete, della storia della tecnica), quale storia dell'uomo.
Si pensi a quei caschi con partitura di colori a spicchi o con stampi di labirintiche geometrie, che, dall'illusoria rappresentazione speculare (o convenzionale: da fotocolor, da rotocalco) rimandano l'osservatore allo splendente ma gelido (disumano, per più di un verso) decorativismo di ispirazione macchinistica di certa, odierna pittura neo-geometrica americana ed europea; e, retrocedendo nel tempo, all'ermetica "cappa" del manichino dechirichiano; e, ancora, alle fonti (all'iconografia quattrocentesca dell'elmo, della corazza o della borchia da bardatura) da cui quel tale motivo del manichino è stato liberamente tratto. Certo, tra un oggettivismo così inteso e le proposte della stessa pittura metafisica, e, più in generale, del "realismo magico" che fa capo ad un determinato filone della Neue Sachlichkeit tedesca corre un filo ininterrotto, anche se sotterraneo: un filo, in ogni caso, più nettamente percepibile oggi nella pittura di Titonel di quanto non lo fosse ieri (in virtù, soprattutto, di quella particolare integrazione del colore nel contesto "documentario", che è intervenuta nel frattempo).
Ma, a questo punto, sarà bene sottolineare - penso - a scanso di equivoci (anche se mi pare di averli implicitamente esclusi un po' dovunque) che Titonel tratta questi suoi temi (sul filo, come si è visto, di un "simbolismo senza apparato simbolico") senza alcun sottinteso di natura nostalgica: da artista radicato nel suo tempo, innamorato dell'"oggetto moderno"; anche se allarmato per le incognite che i conflitti tra la razionalità della produzione e l'irrazionalità del mercato, del consumo (della destinazione del prodotto, insomma) suscita, nel quadro degli odierni sviluppi della tecnica: che, insomma, ogni considerazione sul rimando ai processi di spaesamento messi in moto dal "realismo magico", e, in particolare, a quelli suscitati dalla pittura metafisica, hanno un loro preciso senso solo a patto che si dia per scontata la estraneità dell'autore a quelle particolari forme di disagio e di malessere - storicamente datate - che la esaltante ma caotica e crudele crescita della civiltà urbana e industriale provocavano - in questo o quell'artista della Nuova Oggettività (ed a maggior ragione, ancora, in una personalità come quella di De Chirico, uomo di cultura di formazione neo-romantica, per il quale gli stupori al cospetto della nascente era della macchina erano inseparabili dalle nostalgiche od angosciate riflessioni sulla classicità come "paradiso perduto").
Certo, una volta messo bene in chiaro questo punto, è il caso non solo di indicare ma di sottolineare la crescente propensione per un attivo rapporto dialettico tra documentarismo moderno ed esperienza surreale come il dato caratterizzante - oggi più di ieri - la ricerca di questo giovane pittore impegnato in un'avventura creativa che porta con sé - come tutte le "avventure" - il suo grosso carico di rischi, ma che, se portata avanti nel tempo con la stessa tensione di oggi, può condurlo anche molto lontano.